Sono nata e ho vissuto la mia infanzia ed adolescenza in Salento, quando il Salento non sapeva ancora di essere il Salento. Ho fatto in tempo, quindi, a vivere un contesto sociale che vedeva convivere e intrecciarsi modernità e tradizione, in cui molte dinamiche sociali erano immutate, forse da secoli.
Una di queste, forse oggi ancora viva in alcuni paesi, era la pratica di fare il pane in casa per poi portarlo a cuocere al forno del paese che, oltre a produrre il pane per la vendita, permetteva anche ai privati di cuocere il proprio. Dal momento che il pane salentino ha una conservazione molto lunga, si faceva il pane circa una volta al mese; se ne produceva parecchio per coprire il fabbisogno mensile, e insieme al pane si facevano anche altre varietà di sfornati, fra cui le friselle, oggi apprezzato street food turistico servito con condimenti che fanno inorridire diverse generazioni di miei avi.
Ingrediente indispensabile per fare il pane è il lievito, che allora nessuno chiamava “pasta madre”, ma era semplicemente “llavàtu“. Nessuno era proprietario del lievito: quando una famiglia doveva fare il pane, andava a cercarlo dalla vicina, e dopo tre o quattro porte, in qualche casa si trovava una pagnotta lievitata, che in modo del tutto naturale veniva ceduta alla famiglia panificatrice. Poi, quando il pane veniva impastato e fatte le forme da cuocere, si teneva da parte un pezzettino di quella pasta cruda, si faceva una croce sopra e si lasciava a lievitare per qualche giorno. Si formava così un nuovo llavàtu. Qualcuno del vicinato, qualche giorno dopo, avrebbe bussato a quella porta per prendere il prezioso lievito per il proprio pane, e così avrebbe continuato quella lunga catena fatta di un solo lievito itinerante, che avrebbe fatto lievitare decine e decine di forme di pane, mai uguali da famiglia a famiglia, per tutto il quartiere.
Credo che nessuno di loro avrebbe saputo dire chi, per la prima volta, aveva creato quella pasta madre. Credo anche che nessuno di loro avrebbe saputo farla per la prima volta. Semplicemente, u llavàtu c’era, bastava chiedere in giro.
L’ingrediente primario, il più prezioso, per produrre il cibo più importante dell’uomo, il pane, che anche simbolicamente è sinonimo e archetipo del cibo stesso, non era di proprietà di nessuno. C’era, era di tutti, ciascuno se ne prendeva cura, era una forma atavica di condivisione; nessuno lo “perdeva” mai per incuria, perché smetteva di fare il pane, perché decideva di tenerlo per sé: il lievito restava in vita, si rigenerava, perché tutti lo usavano e riusavano, perché era un bene di primaria importanza per tutti.
Si potevano produrre pane, panini, focacce, friselle, pizze e ogni altra “opera derivata”: nessuno aveva timore di donarlo, perché ce n’era sempre in giro un originale integro.
Per contribuire con la propria documentazione alle celebrazioni per il centenario della morte di Cesare Battisti, la biblioteca decide di digitalizzare le opere che il politico e geografo pubblicò in vita. Decide anche che le digitalizzazioni devono essere disponibili per il pubblico nel modo più ampio possibile, per questo usa piattaforme libere: Internet Archive e Wikisource per i testi e Wikimedia Commons per le immagini. Sono lì, chiunque può trovarle e prenderle per farne qualunque cosa.
Fino a che erano di carta, questi testi interessavano studiosi o studenti di storia e persone interessate alla figura di Cesare Battisti. Che potevano decidere di leggerli, uno per volta, fotocopiarne delle parti, consultare le immagini, citarli come fonte. Con la digitalizzazione questi testi sono stati smembrati: abbiamo il testo integro in formato immagine; grazie al lavoro della comunità di Wikisource abbiamo il formato testo modificabile a fronte (che chiunque può contribuire a migliorare); abbiamo diversi formati dei testi da leggere su diversi dispositivi (ePub, Mobi, Pdf, TXT, RTF) abbiamo le immagini e le carte geografiche fotografate una per una, come singoli oggetti digitali. Sono ancora di grande interesse per gli studiosi, ma chiunque ci può giocare come vuole, può usarli per creare nuovi prodotti dell’intelligenza e della creatività umana, può produrre nuovi strumenti e nuove fonti di conoscenza. Non più e non solo gli storici e gli studiosi, dunque, possono beneficiare di questo lavoro, ma chiunque.
Per esempio, succede che qualcuno , che non è uno storico e non è direttamente interessato alla figura di Cesare Battisti per lavoro o per interesse personale, trovi nell’opera digitalizzata di Battisti una mappa della città di Trento di un secolo fa.
Ispirato da una rappresentazione della propria città che a tratti è rimasta uguale, a tratti è radicalmente diversa a distanza di un secolo, decide di sovrapporre alla mappa antica, una odierna della città di Trento, realizzata in modo aperto e collaborativo nel progetto OpenStreetMap, per creare nuove visualizzazioni che evidenzino tutto quello che è cambiato, e tutto quello che è rimasto uguale, nella città di Trento a distanza di un secolo. 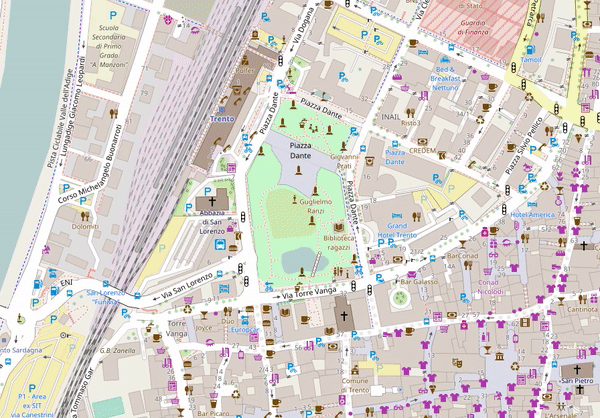
Tutto il percorso, e i risultati di questo lavoro, che mi sembra bellissimo, sono ben raccontati e descritti qui.
Un’opera scritta un secolo fa che, solo per il fatto di essere ora disponibile liberamente in formato digitale, rigenera se stessa e genera nuova conoscenza, mi sembra che possa rappresentare un efficace invito per le biblioteche a non temere di “liberare” i testi in pubblico dominio che conservano: questi, e le loro digitalizzazioni, resteranno integri e correranno solo due rischi che vale la pena di correre: una maggiore diffusione di questi documenti e la possibilità di vedere nascere nuove opere di ingegno e creatività a partire da quelle liberate.
Il bello del pubblico dominio è proprio questo: custodite nelle biblioteche fisiche le opere di carta, le versioni digitali sono sono lì a disposizione di tutti, non bisogna chiedere il permesso a nessuno per digitalizzarle e diffonderle; sono beni che solo con il libero riuso diventano generativi, proprio come quel pezzo di lievito curato e condiviso da tutti, che ciascuno poteva riutilizzare per creare il pane delle forme e ricette più varie.
Anche la conoscenza ha senso se mantenuta viva, se qualcuno se ne prende cura non tenendola chiusa nell’armadio per distribuirla a richiesta, magari dietro compilazione di uno o più moduli, ma lasciando che, come un eterno lievito, possa circolare e venga rigenerata dal libero riuso di chiunque.
Se ha funzionato con il pane, bene di prima necessità, e per secoli, perché allora non dovrebbe funzionare con la conoscenza?