Knowledge Design: costruire nuovi modelli del sapere, è il tema di una conferenza che Jeffrey Schnapp ha tenuto il 16 dicembre 2016 all’Università di Trento, alla quale ho potuto assistere. Qui un resoconto molto parziale dell’incontro, con alcune mie riflessioni. Ringrazio Jeffrey Schnapp per avermi fornito alcuni materiali della sua presentazione.
Il modello del processo di ricerca in ambito umanistico è tradizionalmente quello che parte da un lungo lavoro di reperimento e accumulo di dati, dal loro studio e interpretazione, dalla scrittura dei risultati, dal lavoro redazionale sul testo, fino alla sua pubblicazione. Questo percorso, a volte talmente lungo che la ricerca diventa superata nel momento in cui è pubblicata, è oggi messo in crisi dalle opportunità offerte dagli strumenti digitali, che riavvicinano sempre più ambito scientifico e umanistico, e riportano la conoscenza al confluire di competenze, esperienze, linguaggi più diversi e non ad un preciso ambito definito a priori che si sviluppa secondo un processo prevedibile.
Il modello di digital humanities cui guardare oggi è quello del laboratorio: si fa, si elabora, si produce parlando (ed essendo in grado di interpretare) contemporaneamente linguaggi diversi. Più che di uno staff di ricerca che rappresenta tutte le competenze necessarie, si parla qui di un metodo, che vede nell’annullamento dei confini fra le discipline l’elemento generativo del sapere. Il libro, quindi, può essere solo uno dei nodi all’interno di un processo reticolare che è esso stesso il percorso della ricerca, che si comunica mentre si realizza, mentre si mette in relazione con altre specificità e ambiti inimmaginabili secondo il modello tradizionale di ricerca umanistica.
Il compito dell’umanistica digitale è proprio quello di ridisegnare i percorsi in cui si sviluppano saperi, creando nuovi modelli che includano come parte essenziale del processo di ricerca anche nuove forme di comunicazione, di argomentazione, di “modelli di persuasione”.
Per fare queste cose non bastano studiosi, informatici, bibliotecari, conservatori, artisti del digitale nel senso di professionisti che lavorano in team ciascuno per la propria parte; è necessario che queste competenze attraversino tutte le professionalità, almeno fino al punto di riuscire a parlare un linguaggio comune. Solo su questa base poi possono agire gli specialismi.
L’elemento costitutivo del processo della conoscenza in questo contesto sono naturalmente i dati. Che da soli sono o brutti o inutili, intorno ai quali ruota tutto un lavoro di critica, elaborazione che li rende meaningful or beautiful:
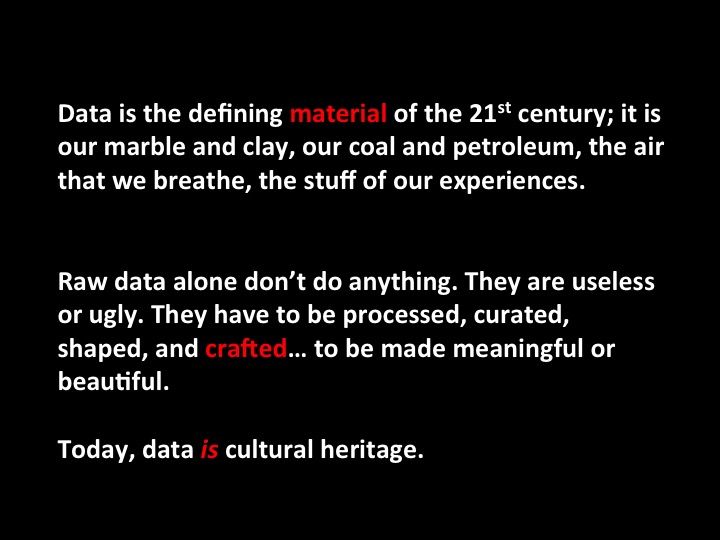
Meaningful and beautiful, mi piace di più.
Non si possono separare infatti i concetti di utile e bello vedendo muoversi sullo schermo una mappa diacronica che si popola, man mano che gli anni scorrono in una colonna in basso a sinistra, di luci più o meno grandi in corrispondenza dei luoghi della storia della stampa in Europa, progetto che alle spalle ha un database di dati bibliografici.
Così come bella, bellissima (e utile, utilissima), è un’immagine che ricorda un quadro astratto: sfumature di tutti i colori che si attraversano ed estendono in aree più o meno vaste, che rappresentano una distribuzione di tutti colori presenti nelle opere di un museo, così basta cliccare su una particolare tonalità per vedere in quali opere questa si trova. Questo grazie a un database in cui i musei buttano dentro le immagini, e poi uomini e macchine fanno il resto. Danno significato e bellezza.
Per chi si chiede quale sia il compito delle biblioteche in questi tempi in cui abbiamo (noi, biblioteche) perso, semmai l’avessimo avuta, l’esclusiva delle fonti della conoscenza, questa a mio avviso è una delle risposte: produrre dati e renderli disponibili. Forse non saremo noi a renderli utili e belli, ma questo lasciamolo fare alle persone e alle macchine che lo sanno fare (se ne parlava anche qui). Nostra è la responsabilità, oggi, di attivare processi che trasformino la conoscenza che le nostre biblioteche conservano in dati, cioè in unità costitutive del sapere in epoca digitale.
Per farne cosa? Credo non debba interessarci più di tanto. Significativa una piccola provocazione che Schnapp ha raccontato: ai bibliotecari della Library of Congress che difendevano la perfezione dei metodi di catalogazione bibliografica da loro utilizzati, egli chiede: “Ma io posso, con i vostri dati, vedere quanti libri azzurri avete?”
Dobbiamo quindi fidarci di quello che chiunque vuol farne, che sia un catalogo dei libri azzurri o un database delle occorrenze di un corpus di testi medievali o una nuova trascrizione filologica di un manoscritto o una mappa tematica di un determinato argomento, o altro.
Tanto, insiste Schnapp, nessuno potrà danneggiarli. I dati resteranno integri, qualunque sia l’uso che se ne faccia.
Sarà questa la nuova identità delle biblioteche, sono questi gli scenari futuri? Mi aspettavo che, alla domanda sul ruolo delle biblioteche in questi nuovi processi della conoscenza, Schnapp proponesse concezioni ultra-innovative di biblioteche come laboratori di produzione ed elaborazione di conoscenze digitali, e lui ha risposto invece parlando delle antiche biblioteche di Pergamo e Alessandria, che erano ecosistemi della conoscenza: luoghi di conservazione dei documenti, in cui operavano filologi e studiosi che interpretavano e trascrivevano le opere, in cui esisteva una sala che ospitava il confronto e il dialogo e dove si tenevano lezioni. Conservazione, elaborazione, circolazione del sapere avvenivano in un unico processo.
L’epoca digitale ripropone questo processo, che non deve però isolarsi nel solo contesto digitale anzi: oggi come allora sono fondamentali gli spazi fisici, luoghi dove far interagire le persone intorno alle risorse della conoscenza.
Fino ad ipotizzare proposte audaci per le biblioteche pubbliche locali: collezioni mobili e collocazioni temporanee, che forniscano alle persone tutti gli elementi di conoscenza per la discussione e l’elaborazione partecipata di determinati problemi molto sentiti dalla comunità. Una proposta alternativa al modello di biblioteca pubblica universalistica che varrebbe la pena di sperimentare.