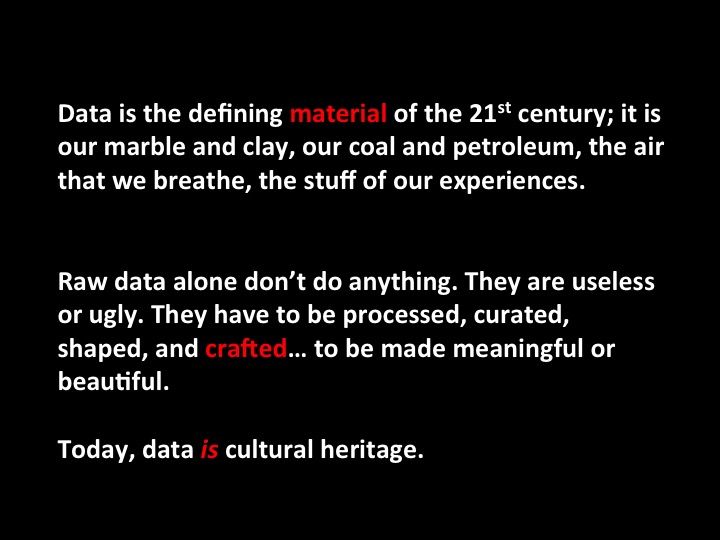È uscita una bella intervista a Tommaso Paiano, bibliotecario nelle Marche, che parla di molti temi interessanti, alcuni dei quali neanche toccati, oppure appena sfiorati dal dibattito professionale (e non) sulle biblioteche.
Parla, e molto, dell’aberrazione del precariato in ambito culturale; parla delle biblioteche che sono fatte di relazioni, prima che di libri; che sono motore di emancipazione e riscatto sociale delle persone; e a un certo punto parla di quanto poco importi, alle amministrazioni e – lo sento dire, scrivere per la prima volta – ai cittadini stessi, delle biblioteche. Tutti dicono che le biblioteche sono una buona cosa, ma quanto poco viene dato, e quanto poco viene richiesto, in termini di finalità e di progettualità, alle biblioteche?
Ma c’è un punto che ho riletto più volte, mi ha fatto pensare e mi ha spinta a scrivere questo post:
La vulgata è: siccome l’Italia è un paese di analfabeti funzionali i servizi culturali servono a rimettere dritta la barra, perché sennò l’ignoranza fa diventare la gente delle bestie. […] Al momento, quindi, la discussione più interessante che c’è è quella che affronta l’analfabetismo funzionale, condotta in sostanza da “benestanti” che si occupano un po’ paternalisticamente dei poveri, ma non ci sono poveri che con il coltello tra i denti rivendicano biblioteche e servizi per cacciarsi fuori dai guai.
La rapidità e i meccanismi sociali per cui stiamo diventando delle bestie sono sotto gli occhi di tutti (coloro che vogliano vedere). E sono piuttosto scoraggiata rispetto a quanto possano incidere le biblioteche italiane per contrastare questa realtà. Intanto, perché sia i servizi delle biblioteche pubbliche, sia l’utilizzo che ne fanno gli utenti, privilegiano l’intrattenimento, più che informazione: il 25/30% circa dei prestiti delle biblioteche pubbliche sono DVD, cioè film; non ho trovato dati precisi, ma a spanne un altro 25-30% riguarda opere di narrativa. Poi, per quanto grandi siano i nostri sforzi, noi comunque arriviamo a chi probabilmente ha già gli strumenti per cavarsela: le persone consapevoli dei propri bisogni informativi, culturali, di svago che già frequentano le biblioteche. Le strategie con cui finora abbiamo cercato di avvicinare nuovi utenti non hanno funzionato più di tanto: la percentuale di popolazione che le frequenta resta invariata nel tempo e presenta oggi preoccupanti segni di diminuzione.
Chi più direttamente si è impegnato sul contrasto all’analfabetismo funzionale difficilmente è riuscito a creare impatto: l’incontro sulle fake news, il corso sugli strumenti per reperire informazioni corrette in rete, il laboratorio di Information Literacy, la mostra bibliografica sul tema d’attualità, sono tutte cose lodevolissime, su cui bisogna continuare a insistere, ma hanno un limite: difficilmente arrivano a chi ne ha bisogno. O almeno, difficilmente arrivano a chi ne ha un bisogno disperato. Perché se la società, la politica, le dinamiche dei social non salvano, ma anzi spingono sempre più nell’ignoranza chi non ha o non vuole usare gli strumenti per formare, esercitare e accrescere il proprio senso critico, se non ce la fa la scuola, sarà difficile che la biblioteca possa essere più incisiva.
Solo su un punto dell’intervista a Paiano non sono d’accordo, per niente:
“non ci sono poveri che con il coltello tra i denti rivendicano biblioteche e servizi per cacciarsi fuori dai guai”.
Non è vero. Non hanno il coltello fra i denti, perché la maggior parte di loro sono persone miti e cercano invisibilità, ma i poveri che rivendicano biblioteche e servizi per cacciarsi fuori dai guai ci sono, io li vedo ogni giorno. Non bisogna neanche andare a cercarli fuori, perché le biblioteche le frequentano. Li chiamiamo “utenti impropri”, oppure “quelli che non fanno niente”. Sono quelli con i quali difficilmente si attivano relazioni, anche se quello del bibliotecario è un lavoro di relazione. Sono quelli che non rientrano nella progettazione dei servizi, perché sono visti come soggetti che non appartengono all’attività della biblioteca. Sono quelli di cui non si rilevano i bisogni, perché per molti dovrebbero stare fuori dalla biblioteca.
Sono quelli che appena arrivano nella nostra città cercano la biblioteca. Perché qui ci sono i computer collegati a internet, c’è una rete wi-fi, certo, ma anche perché in biblioteca c’è una micro-rappresentazione della società che è più decifrabile, protettiva e rassicurante di quello che c’è fuori. La biblioteca è lo spazio pubblico in cui una persona che non ha niente, se non il minimo per soddisfare i bisogni primari, può cominciare a costruire una rete. Di relazioni, di conoscenze, di emancipazione, di sicurezze, di senso.
Questi sono i poveri che chiedono, tutti i giorni, biblioteche e servizi per cacciarsi (o restare) fuori dai guai. Cominciare a considerarli utenti è il primo passo per pensare a loro come destinatari dei servizi della biblioteca ed esplorare i nuovi bisogni cui questi servizi dovranno saper rispondere.